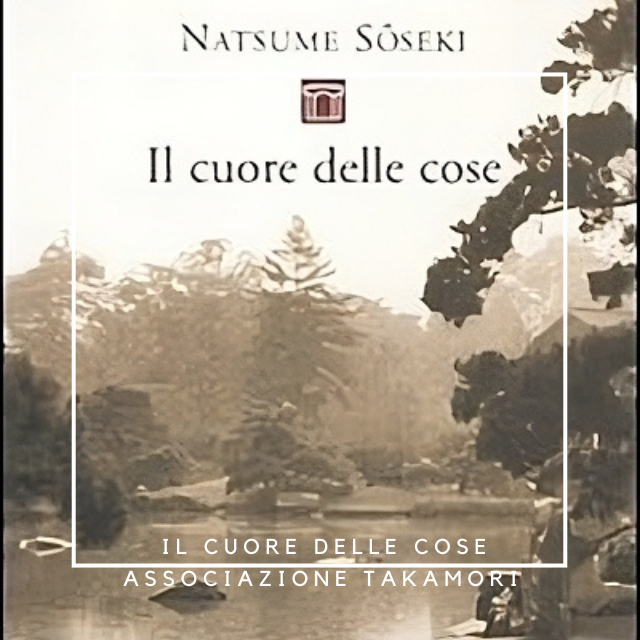
Autore: Natsume Sōseki
Traduzione: Gian Carlo Calza
Editore: Neri Pozza
Edizione: 2006
Il romanzo Kokoro di Natsume Sōseki, (titolo reso in questa edizione con: Il Cuore delle Cose) venne pubblicato in Giappone per la prima volta nel 1914. Venne annoverato in poco tempo tra testi ‘canonici’ della letteratura giapponese postmoderna e tutt’oggi gli è riservato un posto di spicco nella letteratura nazionale. L’autore, Natsume Kinnosuke (1867 -1916) scrive sotto lo pseudonimo di Natsume Sōseki alcuni dei romanzi più rinomati del ventesimo secolo in Giappone, tra cui Io sono un gatto (1905) Il Signorino e Il Guanciale d’erba (1906).
Sōseki ci narra del rapporto tra un giovane ragazzo che studia a Tokyo e il suo sensei, un uomo in cui il protagonista e narratore del romanzo ha trovato un amico e guida spirituale. Già dal primo incontro dei due la figura del sensei si rivela centrale della narrazione, silenziosa ed enigmatica, spesso contraddittoria. Nel corso della storia si rimane stregati da questo personaggio che sembra avere nulla eppure molto da dire sulla vita e in particolare sulla società a lui contemporanea. Nell’ultimo terzo del libro le prospettive si ribaltano e i lettori vengono catapultati nella vita del sensei. Proprio questa si rivela il cuore della narrazione, durante la quale l’animo ed i pensieri del sensei finalmente ci vengono resi noti e attraverso i quali si intravede una realtà che fino a quel momento era stata abilmente nascosta ai lettori.
Uno dei temi centrali del romanzo, come in altri dell’autore, è il sentimento di disagio e repulsione verso l’epoca contemporanea a cui concorre la costante volontà di isolamento e la ricerca costante da parte dei protagonisti della propria identità. Soseki si fa narratore di sentimenti condivisi da molti autori del primo Novecento: il disagio del cambiamento, l’avversione verso i modelli occidentali e allo stesso tempo la consapevolezza di non potersi affidare alla tradizione. Il ‘dramma dell’uomo Meiji’ emerge dalle pagine del romanzo attraverso il personaggio del sensei, forse alter ego dello stesso Sōseki.
Il gesto finale del sensei diventa quindi metafora della transizione dai valori tradizionali ad una nuova e inarrestabile serie di cambiamenti nella società giapponese portati dal confronto e paragone con l’Occidente. Solamente nell’ultimo atto del sensei lui riesce, seppur a caro prezzo, nel processo di autorealizzazione che gli permette di prendere pieno possesso della propria esistenza durante un periodo di cambiamenti radicali, di individualismo ed egocentrismo che si stavano diffondendo sempre più nel Giappone Meiji.
Recensione di Valeria D’Alessandro
Commenti recenti