
Il detective Kindaichi: un caso di delitto (quasi) perfetto
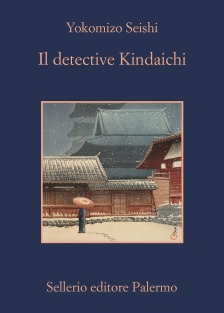
Autore: Yokomizo Seishi
Titolo originale: Honjin satsujin jiken
Editore: Sellerio editore Palermo
Collana: La memoria
Traduzione: Francesco Vitucci
Edizione: 2019
Pagine: 208
Presentare un caso apparentemente impossibile da risolvere è una delle sfide più interessanti che pone Yokomizo Seishi ai lettori nel suo primo libro. Il detective Kindaichi (in traduzione italiana a cura di Francesco Vitucci) è uscito il 4 aprile sotto l’editore Sellerio.
Nel momento in cui si inizia il volume, è necessario dimenticarsi del proprio orgoglio da detective, restituire il badge e appendere la divisa al chiodo. Non importa quanti casi abbiate risolto in precedenza o in quante occasioni abbiate individuato il colpevole già a fine primo capitolo: in questo caso — letteralmente — Yokomizo ha la grande capacità di farvi sospettare di chiunque, di dare ascolto a tutti ma di non credere a nessuno.
Un amore nato sotto una cattiva stella
Quando ci si sente dire di pensarci due volte prima di sposarsi, non ci si dà molto peso. E anche quando si ha la famiglia contro, non si voltano le spalle a un sentimento forte come l’amore. Con queste convinzioni, Ichiyanagi Kenzō e sua moglie Katsuko certo non si aspettavano di essere ritrovati uccisi violentemente in una camera chiusa, per di più la notte stessa delle loro nozze. Eppure, è proprio così che si presentano all’ispettore Isokawa, accasciati l’uno sull’altra in modo quasi poetico. Con i familiari ancora nella magione, appartenente alla famiglia dello sposo, al ritrovamento dei cadaveri si aziona un meccanismo a catena. Questo fa entrare in scena il grande detective Kindaichi Kōsuke, di cui scopriamo il passato e il percorso che lo ha portato a diventare un rinomato investigatore. Grazie al suo acume e alla sua arguzia, uniti alla sua capacità intuitiva e ad un carisma travolgente — che non è fermato dalla sua balbuzie, cosa su cui anzi sembra ironizzare — riesce a risolvere anche questo caso in modo brillante, svelandocene i segreti che non mancheranno di sorprendervi.
«Il caso del koto stregato»
È sotto questo particolare nome che viene presentata la narrazione dei fatti fin dalle prime pagine, le stesse in cui scopriamo le dettagliatissime descrizioni del narratore. Ad alcuni potrebbero risultare macchinose o perfino troppo invadenti ma sono, al contrario, estremamente importanti per poter visualizzare il luogo dove si svolgono le vicende. Yokomizo non vuole avere un rapporto freddo e lontano con quelli che leggono il suo scritto: li prende per mano e li conduce in ogni angolo della magione degli Ichiyanagi, edificio emblema di un sistema feudatario che contrasta per sfarzosità con il resto del villaggio, situato ai piedi della montagna.

Esempio di koto giapponese.
Alla scoperta della mente umana
Piuttosto che tenervi solo sulle spine — dopotutto è anche un noir e non solo un giallo — il detective Kindaichi, protagonista del libro e pupillo di Yokomizo, preferisce concentrarsi non tanto sul come, che comprende e ci svela in un batter d’occhio come previsto dalle voci sul suo conto, quanto sul perché. È qui che riusciamo a intravedere lo scopo dell’autore di ricercare una profondità emotiva e caratteriale nei personaggi di cui racconta, portandone a galla soprattutto le fragilità. Che sia un’influenza di Edogawa Ranpo? Non è da escludere, visto che è stato proprio lui a spingerlo a presentare i suoi manoscritti alla casa editrice “Hakubunkan”.
Ispirazione da tutti, copia di nessuno
Sappiamo però che Yokomizo lavora, per così dire, in un’area differente rispetto a Edogawa. Gli enigmi della camera chiusa sono ciò che lo affascina, tanto che il suo soprannome più comune è «John Dickson Carr giapponese». Tuttavia, ridurlo ad una semplice copia traslata dell’autore britannico è una violenza non indifferente. Yokomizo è un uomo di cultura e, come spesso fa anche Edogawa, cita le sue fonti: i libri che lui stesso ha letto e da cui ha tratto ispirazione sono disseminati come easter eggs all’interno del suo. Sono camuffati in letture svolte dai personaggi, o in semplici volumi che si trovano sulle librerie della storia a prendere polvere.

Yokomizo Seishi, (1902-1981)
Solo un pizzico di magia
Una delle caratteristiche di Carr era il suo essere affascinato dal fantastico, dal soprannaturale e dal magico, che univa sapientemente alle sue storie facendole sembrare mancanti di un’apparente spiegazione razionale. Di questo, Yokomizo mantiene alcune leggende e l’alone di mistero che le circonda, senza mai però eccedere superando il confine dell’oltre natura. Per lui la risposta c’è e non è frutto dell’immaginazione, anche se questa gioca — in un punto preciso della storia — un ruolo rilevante nella risoluzione del caso.
Un consiglio?
Per gli appassionati del genere questo è dunque una perla, il fiore all’occhiello del ventaglio di racconti noir giapponesi dei primi anni Trenta, ora più conosciuti grazie ai racconti di Edogawa, ma pronti ad essere pienamente apprezzati grazie all’aggiunta del romanzo di Yokomizo Seishi, Il detective Kindaichi (模造殺人事件 — Honjin satsujin jiken). Decisamente un must, ora che possiamo usufruirne. L’importante è che non abbiate particolari problemi respiratori, perché — anche se è scontato — vi terrà con il fiato sospeso. Perfino dopo quella che sembra essere la risoluzione del mistero.
— di Francesca Panza
Guarda anche:
IL 210° GIORNO: le critiche di NATSUME SŌSEKI
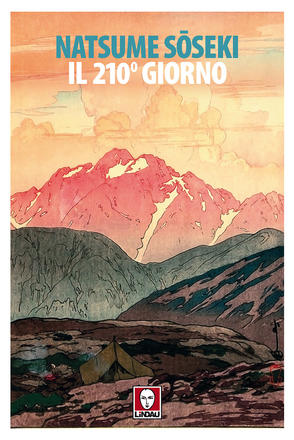
Autore: Natsume Sōseki
Titolo originale: Nihyakutōka
Editore: Lindau
Collana: Senza frontiere
Traduzione: Andrea Maurizi
Edizione: 2019
Pagine: 104
Il 210° giorno, tratto da un episodio della vita di Natsume Sōseki, viene pubblicato per la prima volta nel 1906 sulla rivista «Chūōkōron», ma è edito in Italia solamente quest’anno. Si tratta di un racconto breve, anche per questo a lungo sottovalutato dalla critica, e racconta di due giovani, Kei e Roku, che soggiornano nella città di Aso (nel Kyūshū) con l’intenzione di scalare l’omonimo vulcano per affermare la propria virilità.
Il titolo fa riferimento ad un giorno del calendario lunisolare (abolito dal governo Meiji nel 1873), il nihyakutōka (lett. “il 210° giorno”). In questo particolare calendario erano segnati anche due periodi, sul finire dell’estate, in cui potevano avvenire violente perturbazioni atmosferiche :
- il nihyakutōka, che coincideva con la fine di agosto e l’inizio di settembre cioè, duecentodieci giorni dall’inizio della primavera;
- il nowaki (lett. “erba divisa [dal vento]”),che indicava i tifoni che si verificavano tra duecentoventesimo e duecentotrentesimo giorno dall’inizio della primavera.
Il vento e la pioggia del 210° giorno, insieme alle nubi di cenere vulcanica, agitavano a tal punto la vegetazione che era impossibile distinguere qualunque cosa nel raggio di un centinaio di chilometri. (Il 210° giorno)
Il titolo in sé è una forte critica al governo Meiji, macchiatosi della colpa di avere abolito una tradizione che, in questo caso, avrebbe aiutato i protagonisti a portare termine la loro impresa.
La forza del mutamento
Elementi tipici della poetica di Natsume Sōseki, presente nel racconto, sono i dualismi passato e presente, tradizione e modernità, visibili proprio dalla scelta del vulcano Aso. Infatti essa ricade su uno dei vulcani più alti del Giappone, ai cui piedi sorge lo “Aso jinja”, tempio strettamente legato alla tradizione giapponese. Lo stesso è, non a caso, dedicato Takeiwatatsu-no-Mikoto, nipote del primo imperatore del Giappone, Jinmu.
Con la sua eruzione esplosiva, pone simbolicamente termine a un’epoca- quella del Giappone premoderno – e segna l’inizio di un nuovo importante capitolo della storia del paese. (Andrea Maurizi, Postfazione de Il 210° giorno)
L’eruzione del vulcano pone fine alla tradizione, chiudendo definitivamente con il periodo Tokugawa.”L’evocazione della forza distruttrice della natura in concomitanza di un momento di crisi e di un radicale mutamento delle condizioni storico-politiche”, non fa che sottolineare la traumaticità e la dannosità di eventi forti e inattesi.
Un’amicizia improbabile
Kei e Roku sono l’uno l’opposto dell’altro. Kei è un ragazzo corpulento, figlio di un “produttore e venditore di tōfu” e che ignora la cultura giapponese. Roku, al contrario, è di corporatura minuta, proviene da una famiglia facoltosa ed è molto acculturato. A differenza di Kei, Roku si dimostra poco interessato alla letteratura e cultura “occidentale”; afferma infatti di conoscere La sfida di Iga, ma di non aver mai letto niente di Dickens.
Un’amicizia improbabile quella tra Roku e Kei volta a evidenziare un altro problema dell’uomo moderno: l’individualismo. L’amicizia tra i due è possibile fino a quando la libertà dell’altro viene rispettata, afferma Sōseki. In epoca Meiji, troviamo tra i fondamenti l’esaltazione dell’individuo, per cui ognuno è libero di perseguire la propria felicità, anche se in contrasto con la società; questo porta all’affermarsi del romanzo dell’io, lo shishōsetsu.
Lo smarrimento dell’uomo moderno
Seppure breve, Il 210° giorno racchiude in sé tutta la poetica di Sōseki. Emerge fin dalle prime pagine quello che l’autore identifica come un forte smarrimento dell’uomo moderno, che lascia, in particolare a Roku, un senso di angoscia e inquietudine. Sono infatti molti gli episodi in cui Roku manifesta questi sentimenti.
La forte ondata di “occidentalismo” procura all’ individuo un sentimento di inquietudine e smarrimento. L’Occidente viene preso come modello sia a livello di istituzioni che di usi e costumi; al contempo il Giappone cerca di cancellare, almeno alla vista, elementi che possano richiamare ad una tradizione considerata dagli europei inferiore. Vi è la necessità che il paese appaia forte, occidentale, moderno e colonizzatore, al fine di non essere dominato come gli altri paesi asiatici in quel periodo. Cambiamenti rapidi e veloci non possono fare altro che disorientare l’intera nazione, come lo stesso scrittore afferma:
Il pensiero dell’era Meiji ripercorreva nel giro di quarant’anni tutta la strada che la storia dell’Occidente aveva fatto in tre secoli. (Sanshirō, 1908).
Conclusione
Lascio la conclusione al traduttore di questo racconto breve, Andrea Maurizi:
I riferimenti letterari e […] alla letteratura di intrattenimento del XIX secolo conferiscono all’opera la solidità che solo la tradizione è in grado di assicurare, impreziosendo e nobilitando un racconto che ben si presta a rappresentare lo spessore intellettuale e l’originalità di uno degli scrittori giapponesi più conosciuti e amati in Occidente.
—di Beatrice Falletta
IO SONO UN GATTO (1905) – UN DIPINTO SATIRICO DEL GIAPPONE DI INIZIO ‘900

“Io sono un gatto. Un nome ancora non ce l’ho. Dove sono nato? Non ne ho la più vaga idea. Ricordo soltanto che miagolavo disperatamente in un posto umido e oscuro. È lì che per la prima volta ho visto un essere umano.”
Questo l’incipit del romanzo Io sono un gatto (Wagahai wa neko de aru) di Natsume Sōseki (1867 – 1916), pubblicato per la prima volta nel 1905 ed edito in Italia prima da Neri Pozza nel 2006, e in seguito da BEAT in questa nuova edizione del 2017.
La trama segue le vicissitudini del professor Kushami e della sua famiglia nel Giappone di inizio XX secolo. Il punto di vista da cui vengono narrati gli eventi si rivela essere fin dall’inizio molto particolare: tutto è infatti filtrato dagli occhi del gatto di casa Kushami. Uno sguardo atipico, ma che si rivela filosofico, critico e attento, e si traduce in una voce altrettanto (auto)riflessiva.
Separato dai suoi fratelli e dalla madre, il gatto protagonista giunge dopo varie peripezie nella casa del professore. Purtroppo l’accoglienza riservatagli è praticamente assente, tanto che l’animale rimane senza un nome. Da quel momento ogni giorno osserverà con occhi attenti il professore, la moglie e le figlie di quest’ultimo, oltre alle tante persone che la famiglia frequenta. Alternando profonde riflessioni su tematiche complesse e descrizioni della attività del suo eccentrico padrone, ci offre un quadro della vita quotidiana e uno spaccato del Giappone dell’inizio del secolo.
Una voce ironica da un punto di vista del tutto innovativo
Ambientato più precisamente nel 1905, ci troviamo quasi alla fine dell’epoca Meiji (1868 – 1912). Durante questi anni il Giappone aveva attraversato una complessa fase di modernizzazione, basata sul modello europeo, e aveva visto mutare tutti gli aspetti della vita della nazione. Proprio questo processo è ciò che più aspramente il gatto protagonista critica, facendosi portavoce dell’autore stesso.
Natsume Sōseki, tra i più importanti scrittori del Giappone moderno, è stato spesso definito un “antimodernista”: non per una totale opposizione alla modernizzazione a partire dal 1868 in poi, bensì per l’idea che quel processo così rapido altro non fosse che una mera imitazione di quello avvenuto in Europa attraverso lunghi secoli. In quanto tale esso non poteva che risultare approssimativo. Nel suo romanzo, l’autore dipinge un quadro satirico del proprio Paese, e fa emergere questo suo giudizio in maniera molto innovativa proprio in virtù del punto di vista che sceglie per raccontare la storia.
Si tratta di una lettura divertente e allo stesso tempo ricca di riferimenti intertestuali che rimandano soprattutto alla cultura greca antica, alle filosofie buddhiste e al vasto repertorio di personaggi della tradizione nipponica. L’autore è riuscito a fondere in un solo romanzo tutti questi elementi con un’ironia sottile e graffiante. Un’ironia che la magistrale traduzione di Antonietta Pastore riesce a restituire anche al lettore italiano.
Un romanzo che nonostante i 113 anni dalla sua pubblicazione riesce ancora a coinvolgere appieno il suo pubblico.
Agli amanti dei manga segnaliamo anche una versione molto fedele all’opera originale, pubblicata da Edizioni Lindau e tradotta da Federica Lippi.
—di Giulia Berlingieri
Guarda anche:









Commenti recenti